Luca Vitone materializza le sue opere da un interesse culturale ad ampio raggio particolarmente attento al modo in cui i luoghi si identificano attraverso la produzione culturale: arte, cartografia, musica, cibo, architettura. I suoi lavori si intrecciano con diversi ambiti disciplinari (antropologia, sociologia, geografia, musica, letteratura etc.) inglobati in forme espressive che, sin dalle sue prime produzioni nella metà degli anni Ottanta, sfuggono da ogni convenzione e si pongono al di fuori di generi artisti prestabili. Il confronto con esperti delle varie discipline e la ricerca d’archivio sono parte integrante di un lavoro che antepone la progettualità all’opera finita. Luca Vitone ci racconta del suo primo incontro e interesse per la cultura popolare, come questa ha preso forma nei suoi lavori e cosa ha significato confrontarsi con le istituzioni.

E. G. Rossi: Ci puoi raccontare dove e come è nato questo tuo interesse per la cultura popolare?
L. Vitone: Probabilmente tutto ha avuto inizio grazie a un disco di musica popolare registrato in studio dopo lo spettacolo Bella Ciao de «Il nuovo Canzoniere Italiano», curato da Roberto Leydi e Filippo Crivelli per il «Festival dei due mondi» di Spoleto nel giugno 1964. Tra gli interpreti c’era Giovanna Marini, Sandra Mantovani, Il Gruppo Padano di Piàdena, Ivan della Mea, Giovanna Daffini e Michele L. Straniero. Lo spettacolo proponeva musiche della tradizione popolare italiana seguendo un percorso filologico rivolto a sottolineare il valore culturale di alcune forme musicali caratteristiche del nostro territorio: dal canto di lavoro, a quello politico, dalla canzone d’amore, allo stornello. I miei genitori avevano il vinile e mi piaceva molto ascoltarlo da bambino. Negli anni Ottanta, ho iniziato a ragionare sulla rilevanza dei luoghi per la nostra formazione, su termini come radici, memoria, tradizione, identità. Ho cominciato a lavorare sulla cartografia come elemento rappresentativo, come convenzione di riferimento per la lettura del territorio. La musica popolare mi ha sempre incuriosito e, partendo dal disco citato prima, ho raggiunto altre fonti sonore grazie a collane discografiche come i «Dischi del Sole» o quelli della «Albatros» (la mia preferita). Così ho iniziato a conoscere culture popolari italiane e straniere. Gli etnomusicologi che giravano per le campagne, le periferie, i centri storici, i luoghi del lavoro e quelli dello svago, coinvolgevano cantanti e musicisti -per lo più non professionisti – che interpretavano questa forma musicale prettamente orale, e registravano. Trovavo tutto ciò molto affascinante perché rappresentava un mondo inevitabilmente destinato a scomparire, o per lo meno a trasformarsi. Già il fatto che la trasmissione di questo sapere sia orale, implica che ogni generazione successiva, subendo influenze dalla contemporaneità ne cambi la «tradizionale» interpretazione. Termini come tradizione, memoria, radici, identità, e la stessa cartografia rappresentano una convenzione ideologica di come vogliamo interpretare il mondo passato e reinterpretare quello presente e futuro.
Questo per me era molto interessante ed è ciò che mi ha spinto a lavorare nel tentativo di raccontare il nostro presente attraverso progetti cartografici e, in seguito, l’impiego della musica per la quale, dal 1989, la galleria ha funzionato come una sorta di cassa armonica. C’era una piccola mensola con un registratore di audiocassette portatile che la trasmetteva, diffondendosi per la sala. Il desiderio era quello di sottolineare come questa musica, la cosiddetta folk, fosse testimonianza di un tempo relegato al passato che non potrà più essere presente. Nel momento in cui viene rieseguita, subisce inevitabili cambiamenti che si relazionano al contesto del momento. Inoltre la musica, come il cibo, è un elemento che meglio ci permette un primo approccio conoscitivo a una cultura che non è la nostra, un avvicinamento genuino e diretto. Noi viviamo di alcune convinzioni, che la storia ci ha sempre tramandato. Anche nel momento in cui si parlava di crollo delle ideologie, in realtà alcune collassavano e altre ne approfittavano per trionfare. L’ideologia ci ha sempre coinvolto e, consapevolmente o inconsapevolmente, ha orientato il nostro pensiero. Questo mio lavoro cercava di restituire consapevolezza di sapere per poter controllare questa interferenza ideologica e comprendere quali sono i nostri elementi d’interpretazione; per capire il passato e il presente, per rivolgerci al futuro affrontandolo in maniera meno conflittuale.

Far vivere questi elementi culturali in forme creative, ha significato impiegare modalità espositive del tutto rivoluzionare, soprattutto agli inizi del tuo percorso artistico. Ci puoi raccontare di come questo tuo approccio visionario si sia confrontato con il sistema dell’arte?
Nei miei progetti mi sono avvalso dell’aiuto di professionisti che dal loro ambito contribuissero alla formazione della mia opera. Ho sempre pensato che l’azione principale fosse ragionare sul ruolo disciplinare e sul linguaggio. Quindi c’era sì il desiderio di raccontare con la musica una cultura in via d’estinzione, ma anche quello di presentare una forma diversa di scultura all’interno della galleria che fosse percepibile solo attraverso l’udito. Anche con le cartografie, montate sulle finestre, adagiate sul pavimento o appese nel vuoto, c’era il desiderio di trovare una formula espositiva che non rispondesse ai canoni di riferimento di quel periodo. Allora il mio riferimento erano le esperienze dei decenni precedenti, quelle maggiormente legate ad un’interpretazione analitica dell’arte. Ho cercato di portare avanti un discorso espositivo partendo da quella tradizione, modificandone possibilmente il dispositivo. Ero nei miei vent’anni quando ho iniziato ad intraprendere il primo rapporto professionale con una galleria. Ovviamente erano gallerie giovani che dedicavano molto spazio alla ricerca. C’è da dire che in quel periodo in Italia era difficile confrontarsi con le istituzioni; i musei di arte contemporanea quasi non esistevano. Quando ho iniziato c’era solo il Castello di Rivoli (dal 1984), che ha iniziato a lavorare con la mia generazione dieci anni dopo, e c’era il Pecci (dal 1988). Le mostre si facevano in gallerie private o in spazi fortuiti, grazie al coinvolgimento da parte di un curatore di un’amministrazione o di un privato.

Il tuo lavoro creativo è sempre completato da un confronto e un dialogo costanti con professionisti di diversi ambiti disciplinari. A questo proposito, hai lavorato con l’antropologo Franco La Cecla con cui hai pubblicato «Non è cosa. Vita affettiva degli oggetti – Non siamo mai stati soli». Ci puoi raccontare di questa vostra collaborazione e di come questo libro si è poi trasformato in un workshop al MAXXI?
La collaborazione con personalità di altri ambiti è considerare un arricchimento personale e, come dicevo prima, un escamotage per creare opere, confrontandomi con lo spazio espositivo. Quella con Franco La Cecla è nata quindici anni fa. Ho iniziato a leggere i suoi libri a cavallo del Novanta, e il suo primo Perdersi. L’uomo senza ambiente, un piccolo capolavoro di antropologia che mi affascinò molto. Nel 1994, lavorando a una serie di quindici opere sul ruolo degli oggetti nella nostra esistenza, ho desiderato conoscerlo per chiedergli di collaborare con uno scritto a un catalogo per una mostra in una galleria privata che all’ultimo decise di non pubblicare. A quel punto mi rifiutai di esporre e le opere furono presentate in diverse collettive. In quel periodo, per altri motivi, ho conosciuto gli editori di Elèuthera, con cui Franco aveva già pubblicato Pensare altrimenti, che mi misero in contatto con lui. In seguito ci proposero di riprendere in mano il progetto e di fare il libro, pubblicato per la prima volta nel 1998. Questa raccolta di saggi di Franco sul ruolo dell’oggetto nelle relazioni umane accompagnati dalle immagini delle mie opere e un mio breve testo che le racconta, ha avuto un suo piccolo successo, tanto che siamo arrivati alla sua quarta edizione. Per l’occasione ho mostrato una selezione delle opere appartenenti al progetto in una mostra personale alla galleria Milano, dove, successivamente, abbiamo presentato il libro con Grazioli e Belpoliti e organizzato un concerto per oggetti eseguito da un piccolo ensemble di percussioni diretto da Elio Marchesini. A Roma, parlando con Anna Mattirolo, è venuta l’idea di presentare il libro anche al MAXXI. Da quell’invito è arrivata, grazie a Stefania Vannini, la proposta di un workshop per famiglie, ed essendo per noi un’esperienza inedita l’abbiamo subito accettata. Di workshop ne avevo condotti abbastanza per partecipanti di varie età e categorie ma sempre in modo individuale. Quest’idea di coinvolgere dei nuclei famigliari non mi era ancora stata proposta e mi era sembrata una bella intuizione proprio perché gli oggetti raccolgono l’intimità e la memoria di una famiglia. Quindi abbiamo invitato tre generazioni diverse: nonni, genitori e nipoti e tutti hanno portato, cosa non scontata e a conferma del nostro pensiero, oggetti non preziosi in senso economico. L’oggetto è un condensatore di memoria, legato alle persone che l’hanno custodito, che viene così tramandata da una generazione all’altra o, se è di diretta acquisizione, ricorda un accadimento importante, di cui è testimone. È stato interessante ascoltare il confronto e il diverso modo di relazionarsi nel racconto del ricordo tra nipote e nonno, genitore e figlio, maschio e femmina. È stata una giornata ricca di racconti. Franco ha tanta esperienza alle spalle, è un grande affabulatore e ha raccontato parecchio, cose divertenti e interessanti, anche di culture lontane. In seguito al workshop c’è stata la presentazione del libro nella galleria all’ultimo piano del museo e con noi e i rappresentanti del museo c’erano i gemelli Gianni e Giuseppe Garrera, che sono stati molto brillanti. Era la giornata del contemporaneo, la sala era gremita e si è rivelata una serata riuscita.
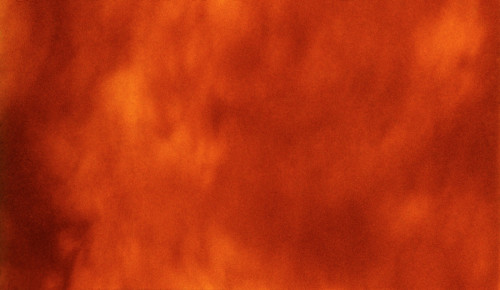
Tra i numerosi eventi – in corso e a venire – che includono tuoi lavori, c’è anche la mostra Collezionare per un domani. Nuove opere a Museion ( curata da Letizia Ragaglia) a Bolzano. Ci puoi raccontare del tuo lavoro in collezione? Per collezionisti pubblici o privati esistono clausole particolari (in relazione, per esempio, alla conservazione) nel caso in cui si tratti di opere che includono anche componenti effimere?
Ho due opere in collezione a Museion. La prima, Le ceneri di Milano, è stata acquistata per la mostra di apertura della nuova sede del museo sotto la direzione di Corinne Diserens nel 2008 e fa parte di una serie di opere monocromatiche fatte con le ceneri di un termovalorizzatore milanese in occasione di una mostra da Emi Fontana del 2007. La seconda, Rogo, è stata prodotta e acquisita su invito di Letizia Ragaglia per una personale, Monocromo – Variationen, fatta nel 2012 e si tratta di una pellicola in 16 mm, che riprende in primo piano il fuoco del termo-valorizzatore di Bolzano, anche questo un monocromo dedicato alla polvere e allo scarto. Per arrivare alla seconda parte della domanda direi che le clausole per la conservazione si basano innanzi tutto sul buon senso, in certi casi ci sono delle regole di prevenzione da seguire che vengono concordate nell’atto dell’acquisto. La tutela della proprietà materiale dell’opera è affidata alla responsabilità dell’istituzione. Museion e le istituzioni pubbliche e private – in generale – adottano un sistema di controllo sulla collezione molto attento che difficilmente porta a disattenzioni. Le componenti effimere sono una costante nella produzione contemporanea e, a parte il fatto che nel tempo i materiali utilizzati sono sempre più deperibili e necessitano una maggiore attenzione, hanno spesso bisogno di una manutenzione per il loro funzionamento e, in certi casi, la necessità di integrare gli ingredienti utili all’attivazione dell’opera.
«Collezionare per un domani. Nuove opere a Museion», a cura di Letizia Ragaglia, Museion, Bolzano, group show, 21 March 2015 – 10 January 2016, questa intervista è apparsa su Exibart.com il 24 aprile, 2015
[nggallery id=69]
immagini (cover e 1) Memorabilia (Alienazione) – 2002 – Teca in plexiglas e specchio con spartito, 35 x 50 x 12 cm. Tiratura 1 di 3 esemplari. Fotografia: Shobha. Collezione Micromuseum, Palermo – Courtesy dell’artista (2) Polimnia, 2001. Sgabello, fisarmonica, filo elettrico, lampadine gialle e blu, Dimensioni variabili. Collezione Renato Alpegiani, Torino (3) Eppur si muove (Cartolina), 2003. 1 di 6 cartoline – 10 x 15 cm. Courtesy dell’artista (4) Liberi tutti! (Elèuthera, Carrara), 1997. Fotografia a colori – Fotografia: Luca Vitone – Courtesy dell’artista (5) Rogo, 2012. Fermo immagine del video. Proiezione da pellicola Super 16 mm – 2’ 22’’ Loop. Courtesy Luca Vitone e Museion, Bolzano








































