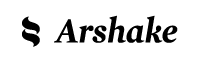Oggi Arshake ha il piacere di pubblicare la quarta di otto tappe del viaggio di Pasquale Polidori a Kassel in occasione di Documenta 14, manifestazione quinquennale tra le più importanti al mondo.
Siamo tutti servi (ma il padrone non esiste).
Il servo enumera, paese per paese, le conquiste del padrone. Il padrone, da parte sua, neanche se le ricorda, essendo troppo impegnato ad amare. Per lui ogni volta è l’unica volta. Ma il servo tiene il conto di tutte le volte passate: il servo è il custode del catalogo, della memoria e dell’atlante dei significati.
Non è per niente facile capire, qui, chi sia il padrone, ossia chi si consuma nel piacere dell’opera, lasciandosi assorbire, ogni volta, ad ogni opera, assolutamente, indefinitamente, tanto da scordare la mappa generale. Forse, addirittura, il padrone non esiste (e di sicuro non è l’artista), non esistendo affatto la possibilità di un godimento nell’oblio della critica, o inconsapevolezza del catalogo. Ma certo il servo, colui che fatica per aggiornare la mappa del sapere e delle opere ivi disposte, significato per significato, il servo del linguaggio, quello è il curatore. E il servo è anche il visitatore attrezzato di Maps and Information Booklet, responsabile della propria consapevolezza circa la mappatura del paesaggio estetico/politico che si dispiega davanti ai suoi occhi; invitato a orientarsi da solo, talvolta a cavarsela da solo, nella carenza di note che penalizza molti lavori esposti. (Se lo si fa notare, la risposta è ormai un refrain che ricorre anche in certi musei evidentemente afflitti da senso di colpa curatoriale: “Loro vogliono che tu ti faccia il tuo proprio itinerario”, dice sconsolata la libraia in Friedrichsplatz quando manifesto la mia sorpresa per la mancanza di un catalogo di ‘opere’ e per il fatto che nel Daybook, cioè l’almanacco che raccoglie le schede degli artisti, non siano compresi quelli già morti, e che però in mostra ci sono, semanticamente non defunti).

Perciò, una collana di parole/concetti potrà aiutarci a delineare almeno i punti chiave (quelli che sono riuscito umilmente a individuare) di questo ricco paesaggio/catalogo.
(1) La prima parola è senz’altro partitura, nel senso musicale e coreografico del termine, ma anche nel senso più generale di modello linguistico o comportamentale da eseguire; scrittura; disegno destinato all’atto interpretativo; istruzioni e non-istruzioni. (2) Poi, aggettivata come si conviene ad un concetto che, grazie al femminismo, ha almeno 50 anni di vita artistica e riflessione filosofica, la parola corpo: corpo politico; corpo collettivo e parlamentare; corpo performativo; corpo significante/significato; corpo/indice; corpo/strumento; corpo come anatomia concettuale; corpo in transito: tra i generi, tra materia e linguaggio, tra storia e presente, tra la vita e la morte. (3) La centralità del corpo è ulteriormente riaffermata dalla presenza di non pochi lavori basati sulla maschera, e anzi è proprio nel concetto di maschera che si intrecciano varie linee qui presenti: democrazia e teatro; rito, memoria e comunicazione; manufatto artigianale e artefatto culturale; soggetto psichico e soggetto sociale; e la dialettica tra ‘statua’ e ‘maschera rituale’, che si situa proprio al centro della classicità (non solo) greca. (4) Letterale e traslata, o soffiata come un vetro la cui materialità è sempre effetto di forze trasparenti, vi è la parola restituzione, riferita non solo alla violenta spoliazione subita dagli ebrei per opera del nazifascismo, ma anche alla secolare repressione dell’identità culturale e negazione dell’autonomia storica e politica su cui si è basato il rapporto di egemonia tra colonizzatori e colonizzati; e restituzione, anche, all’interno di una ritualità domestica o cittadina, di un equilibrio psichico, biografico, affettivo, narrativo, alle vittime della guerra; restituzione, infine, dei significati dovuti alla storia del Novecento, alle avanguardie, alle ideologie egualitarie e antifasciste, ai progetti intellettuali che hanno mosso e formato le vite individuali. (5) Infine, la parola confine e i suoi sinonimi: ‘frontiera’, ‘steccato’, ‘recinto’, ‘parete’, ‘muro’, ‘linea’. Declinata in molte opere, fra video, scultura e pittura, l’idea di confine salda l’antropologia con l’architettura, l’astrattismo geometrico con il documentario fotografico, la geopolitica con la biopolitica.

Dunque: partitura, corpo, maschera, restituzione e confine. Una esigua collanina che non pretende di esaurire la tematica di un tale labirinto dove, riflessi negli specchi, ricorrono i soliti concetti oggi moneta corrente di ogni pensiero che si dichiari, politicamente, critico. Ma, come dice la libraia: a ciascuno il suo itinerario.
… to be continued…
Pasquale Polidori è artista e filosofo multimediale e multidisciplinare, sperimentatore di ogni mezzo (tecnologico e non) che possa estendere la sua pratica estetica che ragiona con particolare forza attorno al linguaggio. Polidori intraprende la narrazione di un viaggio che dalla visita della manifestazione prosegue in una sfera più intimistica, dove ragionare su tematiche universali che ruotano attorno all’arte tutta, al suo modo di occupare gli spazi, di raggiungere il pubblico attraverso il canale istituzionale (o di o di esserne tenuta a distanza).
Post precedenti:
L’unità di luogo è (ormai) impossibile
Documenta 14. Luogo e Topos. Pt.I
Documenta 14. Luogo e Topos Pt. II
Documenta 14, a cura di Adam Szymczyk con un team di circa 18 curatori
10.06-1709.2017, Kassel, Germania (e Atene, fino al 16 luglio)
Immagini: (cover 1) Bouchra Khalili, «The Tempest Society», 2017, (Gottschalk Halle) © VG Bild (2) Alvin Lucier, «Sound On Paper», 1985, (documenta Halle) © Roman_Maerz (3) Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi, «Journey to Russia», 2017, (Neue Galerie)